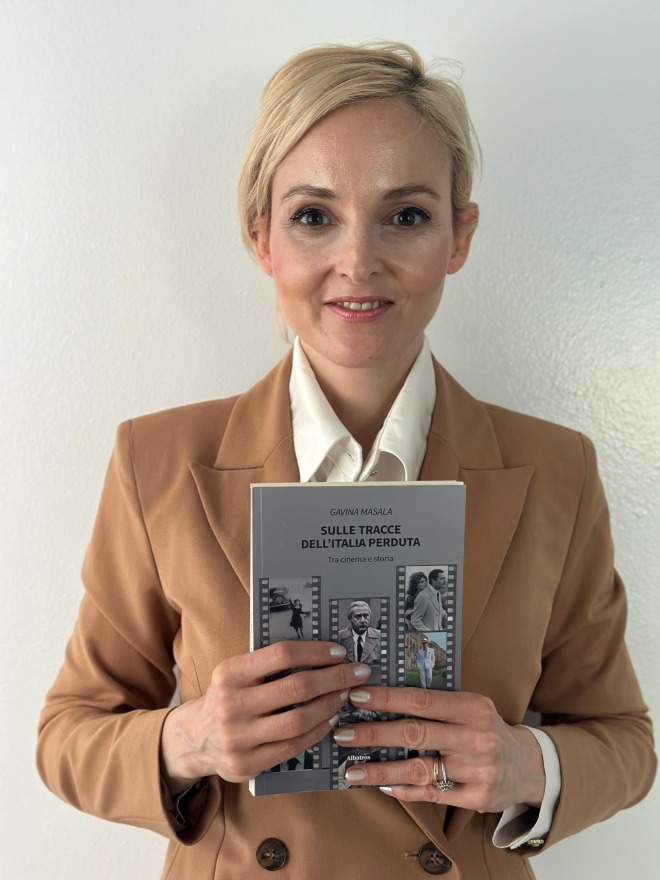Benvenuti al blog del Gruppo Albatros, dove oggi ci immergeremo in una discussione appassionante sulla complessa intersezione tra cinema e storia italiana. Siamo entusiasti di accogliere Gavina Masala, autrice del libro “Sulle tracce dell’Italia perduta”, una guida illuminante che ci porta a esplorare le profondità della cultura e dell’identità italiana attraverso il filtro del cinema. Gavina, grazie per essere qui con noi oggi.
Benvenuta, Gavina, e grazie per essere qui con noi oggi. Il tuo libro, “Sulle tracce dell’Italia perduta”, getta una luce affascinante sulla complessa intersezione tra cinema e storia in Italia. Perché un Paese così ricco come l’Italia sembra costantemente sull’orlo di un non ben precisato pericolo? E perché figure come Moro e Pasolini restano così fondamentali anche oggi?
Moro e Pasolini sono state figure fondamentali per il nostro Paese. Al contempo costituiscono due importanti rimozioni operate ai danni del nostro presente repubblicano. L’omicidio di Aldo Moro nel 1978 ad opera delle Brigate Rosse ha creato uno spartiacque, un “prima” e un “dopo”. Se ci pensiamo, da quel momento, la politica in Italia è andata declinando, per non riprendersi mai più, avvitandosi in manifestazioni ben lontane dall’ardire concettuale e sinceramente politico che animò l’ultimo statista che l’Italia abbia avuto. Se riflettiamo sul cinema, dal 1978 in poi la politica è scomparsa anche dagli schermi, un silenzio eloquente. Da quel momento, il cinema si è dedicato maggiormente a descrivere il declino culturale e antropologico dei “tempi impoetici” che viviamo. Non è un caso che sia stato Marco Bellocchio a fare nel 2022 un film politico partendo proprio da Moro, rendendo bene l’idea del deserto che abbia lasciato dietro di sé e di quanto egli avesse preconizzato quell’aridità che stava arrivando e al contempo avesse cercato di guardare oltre. Moro fu lasciato solo e questo dal film di Bellocchio è molto chiaro. Grande preconizzatore, al punto da sembrare quasi anticipare i nostri tempi, fu Pier Paolo Pasolini, intellettuale nel senso pieno del termine: capace di trovare nessi, di leggere dentro i fenomeni e di guardare al futuro. Anche lui fu lasciato solo. Pare evidente che a noi italiani la consapevolezza pesi, che la luce che squarcia l’ombra non ci rassicuri, paradossalmente. Il vuoto che Pasolini profetizzò è tutt’ora in atto, più che mai. Il talento di Pasolini fu multiforme, ma trovo che la sua capacità di analisi sia stata il suo maggiore pregio, l’avere intuito che la morfologia del potere stesse mutando, in virtù del primato dell’economia su tutti i saperi, le arti e la scienza. Che questo avrebbe cambiato definitivamente gli italiani, penso non possa negarlo nessuno. Basti pensare a quanto sia mutato l’uso della lingua italiana dall’introduzione delle TV commerciali, per fare solo uno dei tanti esempi possibili. Ambedue le figure sono emblematiche proprio dell’intersezione di cinema e storia: Moro fu un cinefilo molto attento e Pasolini addirittura regista, perché il cinema innegabilmente ha un potere di immediatezza, dovuto al primato dell’occhio sugli altri sensi. Tradurre una pagina di storia sullo schermo è un’operazione ricca di insidie, ma sempre feconda, in quanto vedere aiuta a capire non solo i meri eventi storici, ma consente di ricostruire un contesto, una condizione che li abbia contraddistinti. Perché l’Italia è sull’orlo di un non ben precisato pericolo? Perché sembra ci impegniamo a sopire quella spinta culturale che dovrebbe contraddistinguerci. Perché abbracciare quella caratura culturale che contraddistingue il paese costa fatica e impegno. Pensiamo a una città come Roma, che tanto amo, a quanto perfino gli abitanti non la conoscano. Ma la bellezza è tale solo se si compia lo sforzo di dialogare con essa, altrimenti rimane insignificante seppur piena di significati. Io credo che siamo in pericolo se perdiamo la nostra radice, che è inesorabilmente fatta di cultura, ove per cultura intendo storia, arti figurative, cinema, musica e tradizioni. La varietà antropologica, ambientale e linguistica italiana poi è unica al mondo. L’unico modo per non essere condannati al ruolo di gregari nello scacchiere internazionale, o per non involverci definitivamente, è conoscerci. “La grande bellezza”, il film di Paolo Sorrentino, ci lascia con un sentore di speranza. Dopo avere messo a fuoco il degrado culturale e non solo che viviamo, Jep vive un momento di rinnovata consapevolezza. Speriamo succeda anche a noi.
Potresti condividere con noi le tue riflessioni su come il cinema abbia saputo fornire risposte originali a questi enigmi e analizzare lo scenario italiano meglio di molti manuali?
Il cinema rappresenta l’emozione sensibile, la storia l’astrazione concettuale. Se partiamo da questo assunto e dal presupposto che il cinema italiano non sia un’industria, ma un prodotto autoriale, capiamo quanto potere evocativo e culturale abbia la settima arte. Facciamo un esempio paradigmatico: si può spiegare la Resistenza italiana susseguente al secondo dopoguerra, ma quanta eloquenza nel lungo piano sequenza in cui Anna Magnani corre verso il suo uomo catturato dai tedeschi – ora nemici in casa – e verso la sua morte. Oppure: capire quanto sia stata gravida di conseguenze la convivenza con i tedeschi dopo l’armistizio risulta esercizio più immediato se ricorriamo, oltre che ai libri di storia, alla pellicola di Rossellini. L’effetto è da attribuirsi alla possibilità di ricreare una temperie, anche se non si spiega l’evento in maniera didascalica, esso è comunque sempre sotteso. Si può anche pensare alla commedia all’italiana, che con occhio ironico, talvolta satirico, coglie tutte le pecche dell’italiano, quasi che portarle sullo schermo possa avere effetto catartico. Pensiamo a personaggi quali Cetto La Qualunque o a Furio Zoccano di Bianco Rosso e Verdone, o a Fantozzi, che stigmatizza i soprusi e le escamotages che contraddistinguono l’esistenza di un impiegato. Tutti questi film ci aiutano a scrutare le profondità del nostro animo, anche le più recondite, per liberarci di ciò che ci rende mediocri o, peggio, disonesti.
Uno degli aspetti intriganti del tuo lavoro è l’analisi del declino economico, morale, politico e culturale dell’Italia dalla seconda metà degli anni Settanta. Potresti illuminarci su quali siano le cause di questo fenomeno e come il cinema italiano ha riflettuto questa complessa realtà?
Gli anni ’70 sono stati, a mio vedere, fondamentali per l’Italia. Se da un lato si affacciava sulla scena pubblica il movimentismo, che tanto ha contribuito al progresso del Paese, al contempo il boom economico faceva intravedere le sue fragilità strutturali. Le spinte dei movimenti non riuscivano ad essere assorbite dalla società, e così quest’ultima diventava sempre più conflittuale, quasi che non sapesse a quale meta tendere. Un ventennio dopo il sistema di corruzione e favoritismi che caratterizzò l’Italia esplose in “mani pulite”. Gli anni ’70 furono anche quelli in cui emerse con maggiore forza la figura adamantina di Aldo Moro, molto vicino a Paolo VI. Proprio negli anni ’70 Moro capisce e manifesta l’esigenza concreta, suffragata dai numeri dei votanti PC, di alleare la DC con la parte progressista del Paese. Con l’assassinio di Moro si è posta la pietra tombale sulla politica italiana e, probabilmente, sulla parte migliore del Paese, quella abituata a farsi strada con il proprio intelletto e capace di ragionare in maniera politica. Sono anche gli anni di scandali politici, quale il Lockheed. Moro stesso diceva: “Devo riconoscere che da anni qualcosa è guasto”. I tempi de “La dolce vita” sono lontani, anche se nel libro specifico come già nella pellicola di Fellini si ravvisassero dei prodromi di decadenza. Sono gli anni di “Un borghese piccolo piccolo”, gli anni di Alberto Sordi, che porta sullo schermo i vizi degli italiani, quasi a volerci scorticare, per guarirci. In “Un borghese piccolo piccolo” poi, a mio vedere, vediamo anche la solitudine del protagonista, abbandonato dalla società, dai colleghi, dalle istituzioni nell’immane tragedia che lo ha visto protagonista, ovvero la morte di un figlio. Ma non è forse ciò che avviene nella realtà? È il primo ruolo drammatico per Alberto Sordi. Qualcuno dice che il film rappresenti la fine della commedia all’italiana, perché la pellicola finisce per assumere i tratti del dramma. Troppe, dunque, sono le strade che ci portano a pensare che gli anni ’70 siano stati cruciali anni di crisi.
Nel tuo libro, evidenzi la bellezza e l’originalità della cinematografia italiana, anche in periodi di crisi. Potresti condividere con noi alcuni dei veri capolavori che ci possono guidare nel decifrare il carattere controverso ma affascinante del nostro Paese?
I sette film che ho analizzato nel libro sono dei pilastri ineliminabili per chiunque voglia avvicinarsi a una comprensione profonda dell’Italia. Sono gemme di autentici maestri: “Roma città aperta” di Roberto Rossellini, “La dolce vita” di Federico Fellini, “Il sorpasso” di Dino Risi, “Un borghese piccolo piccolo” di Mario Monicelli, “La terrazza” di Ettore Scola, “Bianco, rosso e verdone” di Carlo Verdone e “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Tutte queste opere hanno in sé la caratteristica di catturare un momento storico particolare, o un tratto comportamentale controverso. Prendiamo ad esempio “La terrazza” di Ettore Scola, in cui il regista stigmatizza il comportamento della classe intellettuale di sinistra, cui egli stesso appartiene, con pregevole onestà intellettuale. Nel film sembra concretizzarsi la profezia di “vuoto” enunciata da Pasolini pochi anni prima. Se leggessimo solo la tematizzazione pasoliniana, senza vedere il film, potremmo pensare che si trattò di un fenomeno circoscritto, magari lontano da noi. Il vedere, invece, ci avvicina alla consapevolezza piena e, probabilmente, alla voglia di porre argine a quel degrado culturale che Scola mette a fuoco. Oppure prendiamo “Bianco, rosso e verdone”, in cui il regista, attraverso tre tipologie di maschere, ci guida nella difficoltà antropologica che gli italiani degli anni ’80 stavano vivendo. Peraltro, nel film la tematica politica fa da sfondo a vicende umane tanto rocambolesche quanto esplicative di quel vuoto che Pasolini ha messo a tema. È come se i personaggi si avvitassero su se stessi. Siamo nell’Italia immediatamente susseguente all’assassinio di Moro e tutto sembra già mutato, avere perso di spessore. La spinta vitale del Paese non si traduce in un’enfasi politica, dunque tutto assume un connotato stanco, a tratti grottesco; le persone sono superficiali, a volte maniacali, mai vibranti, mai intense. È come se la rassegnazione fosse la chiave di lettura dei tempi moderni. In ultimo, vorrei ricordare quanto nel film “La grande bellezza” vi sia ben poco di bello. Roma stessa ignora la sua bellezza, tranne che per una piccola sequenza di scene in cui Ramona, vera metafora della città, ne rimane ammaliata.
Infine, potresti raccontarci un po’ di più su come hai concepito questo libro e quali sono stati i tuoi principali obiettivi nel cercare di rintracciare le radici profonde del “declino italiano”?
Innanzitutto, mi preme ribadire quanto io sia partita da una spinta positiva, ovvero il riportare alla luce le ferite dell’Italia, attraverso il doppio binario cinematografico e storiografico, al fine di curarle, certa che la consapevolezza sia il primo passo da compiere. Sono partita quindi da un grande amore per la cultura italiana e per ciò che il Paese, come uno scrigno, racchiude. Poi ho approfondito i dati storici recenti, quelli più dolorosi già citati, e il senso di rimozione e di desertificazione del pensiero che ne sia susseguito mi è stato chiaro. Gli eventi storici non hanno potuto che evocare dei film, segnatamente quelli che ho scelto, che mi hanno aiutata a mettere a fuoco la temperie culturale che ha accompagnato i fenomeni storici. In definitiva io credo che l’Italia abbia ancora molte possibilità di essere un player internazionale di valore, a patto di riacquisire piena consapevolezza di sé.
È stato un vero privilegio avere l’opportunità di conversare con Gavina Masala, un’autrice che con il suo libro ha saputo offrire una prospettiva unica e avvincente sulla storia e il cinema italiani. Grazie, Gavina, per aver condiviso con noi la tua passione, la tua conoscenza e la tua profonda analisi. Speriamo che il tuo lavoro continui a ispirare e a illuminare chiunque sia affascinato dalla ricchezza culturale e storica dell’Italia. Grazie ancora per essere stata con noi oggi.