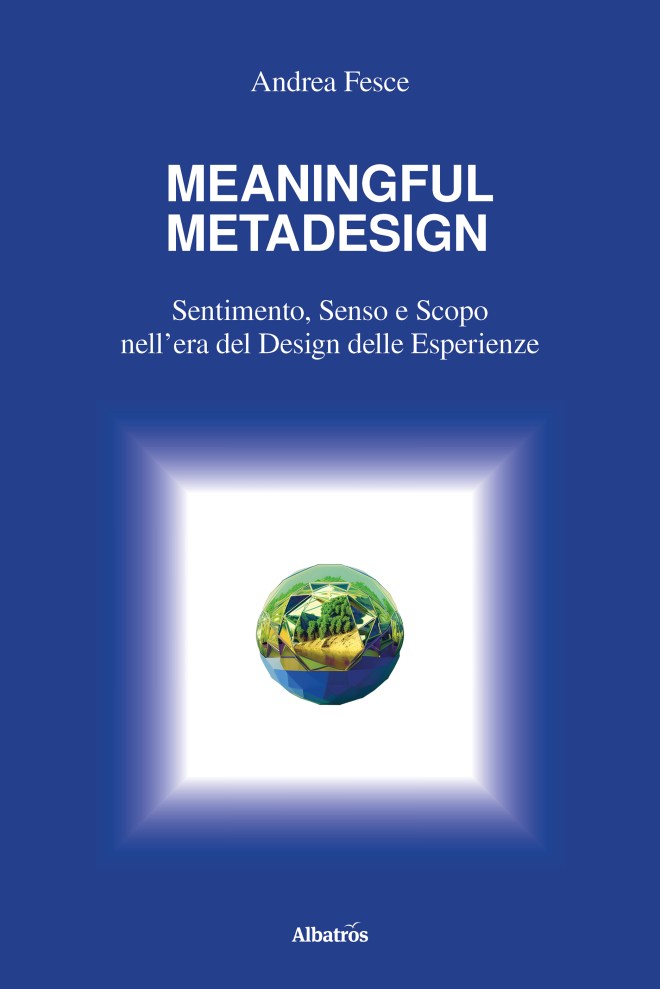Benvenuti al blog del Gruppo Albatros, dove oggi ci immergiamo in un mondo di significato e design con l’autore del libro “Meaningful Metadesign”, Andrea Fesce. In un’epoca in cui il design è spesso associato alla funzionalità e all’efficienza, Fesce ci invita a esplorare un territorio più profondo, dove il design diventa una ricerca di esperienze significative, intrecciando processi interpretativi e qualitativi. Il suo saggio ci invita a riflettere sul contrasto tra il design come creatore di soluzioni concrete e il suo potenziale nel dare forma a esperienze che risuonano nel cuore umano. L’autore ci guida attraverso un viaggio di comprensione del significato del progetto, sottolineando l’importanza di considerare l’esperienza umana come un processo integrato, non deterministico, dove le emozioni e le percezioni giocano un ruolo centrale.
Il suo libro, “Meaningful Metadesign”, pone l’accento sull’importanza delle esperienze significative nel design. Qual è stata l’ispirazione dietro questa prospettiva e quali sono i principali concetti che vuole comunicare attraverso il suo lavoro?
Il mio libro ha indubbiamente lo scopo di focalizzare l’attenzione sull’importanza delle esperienze significative che animano la vita di ciascuno, ma il primo aspetto che mi preme sottolineare è che per me non è rilevante parlare dell’importanza di queste “nel design”, ma bensì nel mondo reale. Mi spiego meglio: se definiamo il design (o progettazione) come la disciplina che si occupa di ideare e creare artefatti (tangibili o meno) con lo scopo di migliorare la qualità della vita degli esseri viventi, possiamo dire che il mio testo non si concentra sui concetti di “ideare” o “creare”, quanto su quello di “qualità della vita”. Qualche lettore potrebbe trovare questa affermazione quantomeno bizzarra, se si considera come siamo immersi in una società fatta sempre più di iper-specializzazioni e nicchie ideologiche. Risulta interessante notare che ad oggi quasi nessuno pensa al progettista come ad un intellettuale che si pone domande in maniera critica circa le complessità e le problematiche del nostro mondo, risulta interessante proprio perché questa è la caratteristica che accomunava tutti i più celebri progettisti del secolo scorso (che fossero architetti, designer industriali o grafici). L’aspetto su cui mi interessa porre l’accento è il seguente: se priviamo il progettista della sua dimensione generativa, la dimensione del “propongo una soluzione progettuale perché consegue dalla mia sensibilità, esperienza e spirito critico”, e se priviamo quindi l’atto progettuale della sua dimensione culturale riducendolo ad artificio tecnico e deterministico (basato solamente su numeri e formule), allora il designer si riduce ad essere solamente colui il quale si occupa di fornire risposte tecniche alle “richieste” poste dai numeri, che nella maggior parte dei casi sono solamente i numeri derivanti dalle ricerche di mercato. Ciò che emerge da questo fenomeno è un loop virtualmente infinito: l’apparato tecnico (inteso come l’insieme delle tecnologie di cui dispone l’essere umano) determina i processi socio-economici e questi a loro volta determinano delle necessità; per soddisfare queste necessità si chiama in campo il design con lo scopo di dare forma ad un artefatto tecnologico (sistema, servizio, oggetto, …) che diventa parte dell’apparato tecnico e infine il ciclo riparte. In un certo senso la società umana è sempre andata avanti così, ma la differenza sostanziale sta nel fatto che laddove prima c’era uno spazio per lo spirito critico e l’approccio culturale all’interno della progettualità, oggi si vuole ridurre il design a una pratica di problem-solving, per cui questi aspetti divengono dei refusi, delle soggettività, del rumore di fondo che deve essere eliminato per non sporcare la purezza e l’oggettività dei dati che interessano al sistema tecnico. Non c’è tempo e spazio a sufficienza per sviscerare la questione in questa sede, ma grandi filosofi come Umberto Galimberti ci hanno insegnato che la tecnica non ha altro scopo che il potenziamento di sé stessa attraverso l’ottimizzazione dei processi funzionali. Di conseguenza, se il design si limita a fornire risposte alle domande dell’apparato tecnico, esso si riduce ad essere strumento di accelerazione ed automazione dei processi… Può questo abilitare delle esperienze di interazione significative e con esse un effettivo miglioramento della qualità di vita percepita (e quindi vissuta soggettivamente)? Tanti autori hanno affrontato queste tematiche prima di me, e in molti casi siamo giunti alle stesse conclusioni. L’unico modo per limitare questa deriva sta a mio parere nel ricercare, come esseri umani prima che come professionisti, un significato, un senso, uno scopo che vada aldilà di ciò che può essere tecnicamente misurato. Questa è la vera importanza del concetto di “esperienze significative” che vanno ricercate attraverso la pratica progettuale: donare alle persone, per quanto possibile, una qualche forma di significato (sentimento, senso, scopo) attraverso le interazioni che intrattengono con la tecnologia che media necessariamente qualsiasi azione all’interno delle società tecnologicamente avanzate.
Nel suo saggio, si discute del legame tra il design e i processi non deterministici del vissuto emotivo umano. Potrebbe approfondire questo concetto e spiegarci come possiamo integrare questa comprensione nell’approccio progettuale?
All’interno del testo parlo spesso di una contrapposizione tra due costrutti che io definisco come “design delle emozioni” e “design per i sentimenti”: il primo si può ricondurre all’approccio preponderante nella odierna cultura del design, il secondo come un approccio per alcuni versi antitetico a cui io e una minoranza di altri autori auspichiamo. Questa contrapposizione rimanda direttamente a quella tra processi deterministici da una parte e processi interpretativi dall’altra. Con la mia riflessione ho cercato di mettere in luce come ad oggi, data la necessità autoindotta di basare ogni nostra scelta su numeri, stime e statistiche, anche l’atto progettuale si basa spesso su misurazioni di fenomeni di tipo fisiologico ai quali si cerca di attribuire un valore qualitativo specifico (bello, brutto, interessante, noioso, e così via) che sia esule da qualsiasi tipo di interpretazione soggettiva o non deterministica. Ora non vorrei essere frainteso, perché tra le mie più grandi passioni spiccano certamente le neuroscienze cognitive e la matematica. Lungi da me, quindi, denigrare la razionalità e il metodo scientifico, ma come sa ogni buon filosofo (inteso come “amante della conoscenza”, indipendentemente dal titolo accademico) prima di affrontare la Scienza bisogna fare i conti con l’epistemologia. Attraverso diversi metodi i neuroscienziati e gli psicologi cognitivi sono oggi in grado di misurare determinati parametri fisiologici e attraverso questi determinare con un certo grado di sicurezza gli stati mentali ad essi associati. Con “stato mentale” in questo caso mi riferisco a ciò che nel libro è definito come “emozione”, ossia l’attivazione di un pattern fisiologico, automatico e geneticamente predeterminato in risposta ad uno stimolo specifico; si pensi allo stress, alla paura, al dolore, al piacere e a questo genere di fenomeni. Senza entrare nel merito di tutte le distinzioni concettuali tra emozione e sentimento (inteso come feeling, vissuto emotivo, come concettualizzato da Antonio Damasio), si tenga conto che con il secondo faccio riferimento a quel fenomeno definibile come la percezione a livello mentale, spesso in forma discorsiva/simbolica e nel lungo termine, del significato che per il singolo individuo viene assunto da un determinato stimolo del mondo (sia esso un’altra persona, un oggetto inanimato, un simbolo, un artefatto tecnologico, …) nel corso dell’intero contesto vitale. Tra questi due fenomeni la differenza è abissale, e per rendersene conto basta pensare ai social network: è facile misurare in sede sperimentale come l’interazione con queste piattaforme abiliti una serie continuativa di scariche di piacere durante specifici momenti dell’interazione (ad es. ricevere notifiche, “scrollare”, etc.); più difficile è invece il dimostrare come questi sistemi generino fenomeni di ansia e depressione in coloro che ne fanno uso frequente e prolungato. Purtroppo non sono in grado di fornire una soluzione ultima o definitiva a questo problema fondamentale legato al disegno e allo sviluppo delle tecnologie future, ma ritengo importante parlarne perché alla fine dei conti, quando si vuole misurare il benessere complessivo dell’essere umano, non c’è alcun dato numerico che tenga: i dati andranno sempre interpretati e l’oggettività sarà sempre una parziale illusione.
Da progetti di comunicazione a interfacce interattive, Lei ha un background diversificato nel campo del design. In che modo questa varietà di esperienze ha influenzato la sua visione del design e come si riflette nel suo lavoro?
Mi piace pensare che il mio background eclettico e i miei interessi variegati abbiano contribuito a rendermi un poco più immune all’omologazione che oggi imperversa nel campo della progettazione e della “creatività” in generale. Non che io pensi che questo nella pratica mi renda un progettista migliore di altri, anzi, purtroppo la mia necessità di dare un significato alle cose e di affrontarle in maniera critica si è rivelato più volte un ostacolo piuttosto che una facilitazione nell’ambito di lavori in team. La triste verità è che è si fa più in fretta a trovare una soluzione che risponde a una serie di requisiti puntuali e che mette d’accordo una maggioranza, piuttosto che trovare una soluzione che soddisfi a pieno due persone intelligenti, competenti e desiderose di affrontare una questione con spirito critico… E soprattutto è ancor più difficile trovare un punto d’incontro tra un gruppo di persone che vuole trovare velocemente una risposta a una domanda e una persona che vuole riflettere su cosa significhi effettivamente la domanda che è stata posta. Per tutte queste ragioni mi sono trovato sempre più a concentrarmi su quella parte della progettazione che viene definita come concept design, o all’interno del mio libro il design for meaning, che ha lo scopo di porsi domande significative e si oppone al design for solutions, che punta a trovare risposte più performanti a tali domande. In un certo senso qualsiasi disciplina progettuale può essere intesa come una dialettica tra queste due operazioni, la mia idea è semplicemente che i progettisti non dovrebbero limitarsi a svolgere la seconda parte così come viene più comodo alla società della tecnica, ma dovrebbero prendersi la responsabilità anche di compiere delle scelte di natura etica circa le reali conseguenze delle loro proposte progettuali (limitatamente a quanto questo sia possibile in un contesto dove ormai nessun individuo può comprendere a pieno la potenza dell’apparato tecnico nella sua complessità). Che ci piaccia o meno, bisogna tenere a mente che i progettisti di oggi contribuiscono in maniera fondamentale al dare forma ai possibili comportamenti, ai significati simbolici, e ai sentimenti che le persone vivranno nel prossimo futuro. Per tutte queste ragioni mi vedo in realtà come un metadesigner, un progettista della progettazione, un teorico, perché il mondo è pieno di professionisti con maggiore gusto estetico, competenza tecnica e voglia di sperimentare rispetto a me, ma quando si tratta di porsi delle domande in maniera critica e integrando insieme numerose prospettive multidisciplinari non mi stanco mai.
Ci parli del suo percorso accademico nel campo delle scienze psicologiche applicate e di come questo si intreccia con la sua passione per il design. In che modo la psicologia informa la sua pratica progettuale?
Se dovessi definire in quale modo la psicologia informi la mia pratica progettuale non saprei rispondere perché per me progettare altro non è che dare forma a significati, concetti, e simboli che si prestano a essere interpretati, e senza la mente umana rimarrebbe ben poco di tutto ciò. Nonostante mi sia iscritto prima alla facoltà di ingegneria del Politecnico e poi a quella di design, ho sempre avuto una passione latente per il funzionamento della mente umana. Fin da piccolissimo la logica è ciò che mi ha appassionato più di tutto: ero un bambino con tante idiosincrasie e tratti comportali particolari (probabilmente anche riconducibili allo spettro autistico), e quando si trattava di memoria, pattern e numeri avevo sempre l’impressione che la mia testa funzionasse diversamente da quella degli altri. Tutto questo era compensato da un profondo analfabetismo emotivo, dato in parte dalle mie predisposizioni e in parte dal contesto familiare, e quando terminate le scuole superiori ho seguito un percorso di psicoterapia per affrontare i miei problemi esistenziali ho imparato ad ascoltare le mie emozioni, seppur in maniera molto razionale ed analitica, e da lì mi si è aperto un nuovo mondo. Io che prima vivevo chiuso nel mio mondo fatto di logica, ho come d’un tratto avuto l’impressione di comprendere chiaramente la logica emotiva del pensiero altrui. Ho quindi proseguito gli studi al Politecnico, ma mentre frequentavo design della comunicazione passavo il mio tempo a studiare linguistica, teoria della comunicazione, semantica e così via. Indeciso su come proseguire gli studi mi sono immerso nelle neuroscienze cognitive e poi ancora durante la laurea magistrale in digital and interaction design mi sono concentrato sempre di più sullo studio dei fenomeni cognitivi nel loro complesso e sul funzionamento dei sistemi tecnologici, andando ben oltre quanto proposto dai professori e disinteressandomi da tutti gli esami che trattavano contenuti puramente tecnici. Con il passare del tempo il design ha smesso di essere un fine per me ed è divenuto semplicemente un mezzo per abilitare l’interazione tra le mie passioni: l’elaborazione logica delle informazioni di sistemi tecnologici complessi da una parte, e la comprensione olistica del vissuto emotivo e cognitivo umano dall’altra. Ciò che ne è emerso è questo libro, il cui testo altro non è che una rielaborazione del mio lavoro di tesi magistrale al Politecnico di Milano, con il quale ho voluto criticare lo status quo delle cose. In questo momento mi manca solo la stesura di una nuova tesi per completare anche il mio percorso di laurea magistrale in scienze psicologiche applicate, ma in un certo senso mi sento di affermare che esso sia stato prevalentemente un percorso necessario ad ottenere un riconoscimento formale per le competenze da me precedentemente acquisite nel corso della vita; quelle stesse competenze che, insieme ai miei valori e alle mie aspirazioni, hanno dato forma a questo inusuale saggio sulla progettazione.
Concludiamo questa illuminante conversazione con Andrea Fesce, un innovatore nel campo del design che ci ha guidato attraverso un viaggio di riflessione sul significato e sull’essenza stessa del progetto. Ci ha insegnato l’importanza di considerare l’esperienza umana come un tessuto integrato nel processo progettuale e ci ha ispirato a guardare oltre la mera funzionalità, verso un mondo di significato e connessione.